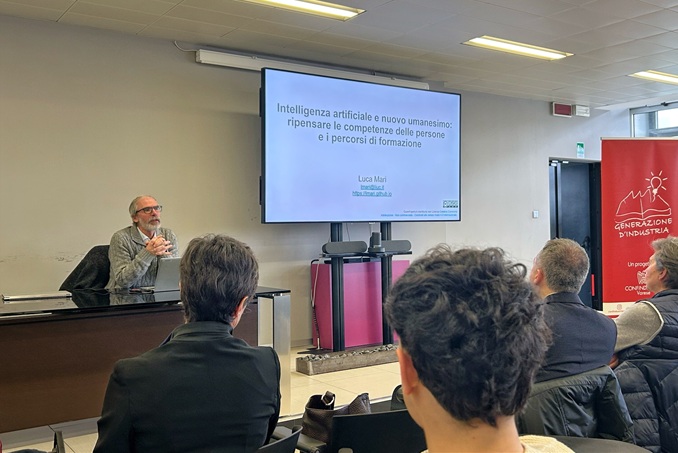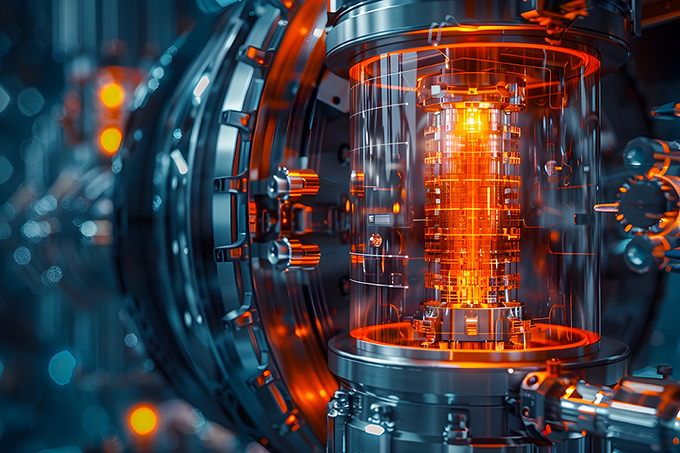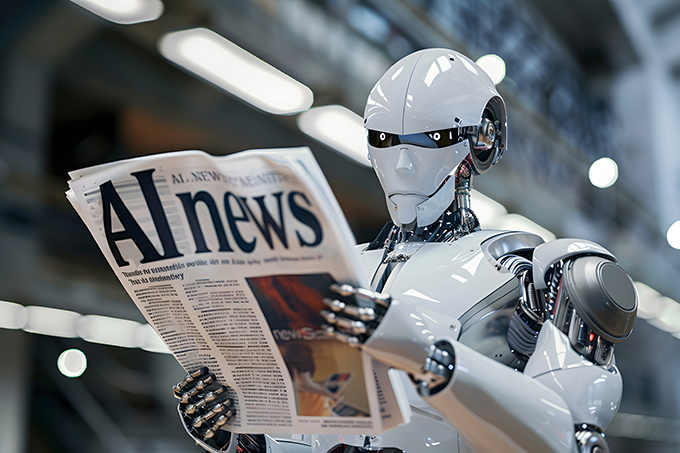È l’inizio di un nuovo mondo
Di sistemi artificiali intelligenti si parla ormai da oltre 50 anni. Quali sono allora i motivi del grande interesse nato negli ultimi mesi intorno a diversi chatbot, potenzialmente in grado di opera
Di sistemi artificiali intelligenti si parla ormai da oltre 50 anni. Quali sono allora i motivi del grande interesse nato negli ultimi mesi intorno a diversi chatbot, potenzialmente in grado di operare come comunicatori o persino artisti? Varesefocus inizia un viaggio sugli utilizzi e le funzionalità di ChatGPT, tra miti da sfatare e cambi di paradigma in atto
La vicenda dei sistemi artificiali progettati per dialogare in lingue naturali, come l’italiano e l’inglese, ha ormai oltre 50 anni, da quando, nel 1966, Joseph Weizenbaum sviluppò Eliza, quello che pare sia il primo chatbot della storia, cioè un (ro)bot capace di chat e di dialogo. Da allora questi sistemi sono stati parte del panorama dell’Intelligenza artificiale, per altro con un ruolo modesto nella percezione sociale. Anche per questo, quanto sta succedendo dal 30 novembre scorso, con l’annuncio della possibilità di interagire liberamente con ChatGPT, appunto un chatbot, merita un’attenta considerazione e non solo per il fatto che a fine gennaio 2023, dunque solo due mesi dopo la sua apertura, pare che questo sistema fosse stato usato già da oltre 100 milioni di persone, arrivando ad essere il sistema digitale che ha raggiunto più velocemente nella storia questo traguardo.
Ciò ha colto di sorpresa molti, anche perché il nucleo del chatbot (chiamato GPT, ovvero Generative Pre-trained Transformer, inizialmente in versione 3 e da metà marzo 2023 anche in versione 4) era disponibile dal 2020 e già nel settembre di quell’anno un quotidiano inglese aveva pubblicato un articolo, intitolato “A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human?” (“Un robot ha scritto integralmente questo articolo. Sei spaventato ora, umano?”), scritto per l’appunto da GPT. Se poi si aggiunge che le fonti da cui ChatGPT attinge si fermano tuttora a settembre 2021, e quindi che il sistema non è in grado di fornire informazione su eventi recenti, ci si ritrova davvero a chiedersi quali siano le cause dell’estremo interesse che si sta manifestando. D’altra parte, quello che sta succedendo non è il risultato di una campagna pubblicitaria di massa da parte di una grande azienda: fino a qualche settimana fa, infatti, in pochi conoscevano OpenAI, l’organizzazione, un po’ azienda e un po’ no-profit, che ha sviluppato GPT e ChatGPT (e Dall-E, un sistema per generare immagini a partire da descrizioni testuali, che ha raggiunto una certa popolarità dallo scorso autunno). Dunque, la domanda sulle ragioni di tutto questo fervore rimane. Cominceremo a esplorarne qui il senso, cercando di giustificare la congettura che quanto sta succedendo intorno a ChatGPT segnala che stiamo plausibilmente vivendo un cambio di paradigma. A tal proposito, proponiamo quella che ci sembra ormai una constatazione: per la prima volta nella storia, è ampiamente diffusa nella società umana un’entità non-umana che mostra di essere in grado di dialogare con noi nelle nostre lingue con proprietà lessicale e semantica, grande eloquenza, abilità argomentativa e accesso a una enorme quantità di informazione.
Insomma, sappiamo quanto sia socialmente rilevante la capacità di una conversazione contestuale, specifica e colta, e, per la prima volta noi Sapiens abbiamo la prova di non essere gli unici ad avere questa capacità. C’è già qui una prima indicazione delle ragioni che potrebbero spiegare l’interesse per ChatGPT rispetto a GPT, che rimane lo strumento alla base di ChatGPT. GPT è capace di interazioni singole (una richiesta, una risposta) e quindi ogni volta che una richiesta produce una risposta, brillante o sbagliata che sia, può rimanere il dubbio che questo sia il risultato di una causa estrinseca e contingente, per esempio che la richiesta fosse semplice da soddisfare o, al contrario, non fosse sufficientemente chiara. Ma ChatGPT è in grado di dialogare, mantenendo il contesto dei contenuti precedenti. L’impressione che il sistema stia comprendendo ciò di cui si sta scrivendo è evidente già al primo uso. Concretamente, ecco un breve e semplice dialogo, realizzato con ChatGPT:
Vorrei che mi aiutassi in una questione di aritmetica. Cominciamo supponendo che x=5, ok?
Certo, posso aiutarti con la tua domanda di aritmetica. Ora che abbiamo stabilito che x=5, quale operazione o problema vorresti risolvere?
Vorrei sapere quanto fa x*2.
Sicuro, posso farlo per te. Se x=5, allora x*2 è uguale a 5*2. Quindi, il risultato è: 5*2=10. Quindi x*2=10 quando x=5.
ChatGPT è in grado di dialogare, mantenendo il contesto dei contenuti precedenti. L’impressione che il sistema stia comprendendo ciò di cui si sta scrivendo è evidente già al primo utilizzo
Prima che ChatGPT fosse reso disponibile, un dialogo come questo (o come quello contenuto nell’articolo “Quando è l’Intelligenza artificiale a scrivere l’articolo”, pubblicato nel numero di febbraio 2023 di Varesefocus, o come quelli che stiamo realizzando e raccogliendo nella pagina web lmari.github.io/chatting) sarebbe stato considerato irrealizzabile (notando tra l’altro che è in italiano e non in inglese), se non forse mediante sistemi accessibili solo a pochi ricercatori. Da qualche mese, invece, è diventata la quotidianità per chiunque abbia avuto anche solo la curiosità di provare. Ci stiamo dunque forse affacciando a un mondo nuovo e ciò grazie al fatto (concettualmente semplice ma dalle conseguenze che solo ora si sta cominciando ad intuire) che queste reti neurali artificiali sono sì sistemi software, ma di un genere completamente diverso da quello a cui siamo abituati: sono sistemi il cui comportamento dipende non dall’esecuzione di regole imposte mediante programmazione, ma da un addestramento realizzato su grandi quantità di dati.
Un comportamento di questo genere sarebbe possibile se ChatGPT non pensasse, capisse, ragionasse. Se siamo abituati da tempo ad agenti artificiali che risolvono specifici problemi complessi, come giocare a scacchi o convertire testi pronunciati in testi scritti, siamo con ciò arrivati a sistemi dotati di Intelligenza artificiale generale, quella che in inglese si chiama AGI, cioè Artificial General Intelligence? Le posizioni al proposito sono diverse. Nell’introduzione di un ampio rapporto tecnico, pubblicato alla fine di marzo 2023 con il significativo titolo “Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4” (“Scintille di Intelligenza Artificiale Generale: primi esperimenti con GPT-4”), un gruppo di ricercatori di Microsoft ha scritto che ChatGPT “dimostra notevoli capacità in vari ambiti e in vari compiti, tra cui l’astrazione, la visione, il coding, la matematica, la medicina, la giurisprudenza, la comprensione di motivazioni ed emozioni umane”. D’altra parte, altri hanno sostenuto che questi chatbot non sono altro che splendidi sistemi di auto completamento e “pappagalli statistici” e che qualsiasi espressione antropomorfa per parlare di essi e del loro funzionamento è inadeguata: la loro non può che essere una “falsa promessa”, perché sono entità capaci di operare ma senza intelligenza.
Queste controversie da decenni accompagnano lo sviluppo dei sistemi cosiddetti di Intelligenza artificiale (per altro senza contribuire in modo così significativo a un chiarimento), tanto che sono spesso trascurate. Infatti, la domanda “Un agente artificiale può pensare?” può tranquillamente essere paragonata alla domanda “Un sommergibile può nuotare?”: si tratta di un quesito mal posto, che potrebbe avere una risposta del tipo “I sommergibili non nuotano, ma fanno qualcosa di funzionalmente analogo”. Non stiamo dunque sostenendo che ChatGPT e i suoi fratelli pensino, comprendano, siano intelligenti “davvero”, anche considerando che non abbiamo dei criteri sufficientemente oggettivi per stabilire cosa debba accadere perché un’entità pensi, capisca e sia intelligente “davvero”. Solo constatiamo che le entità che sono tra noi, spesso mostrano un comportamento che fino a qualche mese fa sarebbe stato considerato proprio dei Sapiens. Il suggerimento, perciò, è minimizzare i pregiudizi e partecipare attivamente a quello che sta succedendo, cercando di capire, sperimentando e confrontandoci (con i chatbot) e tra di noi.