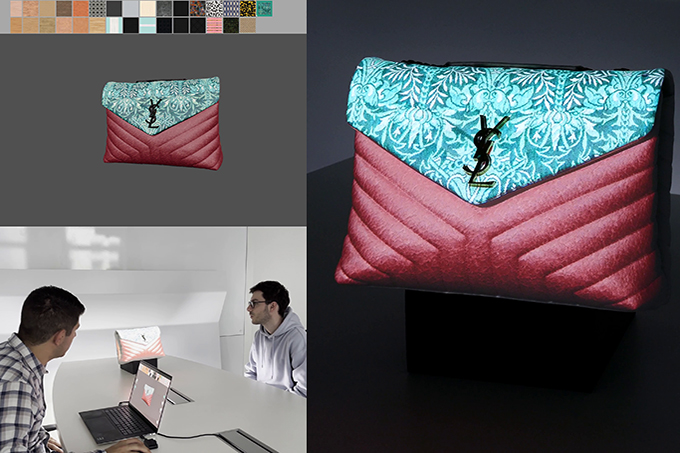La scienziata dell’anno per l’idrogeno è varesina
Gli studi superiori al Liceo Scientifico e una laurea magistrale in Ingegneria Energetica al Politecnico di Milano. Un dottorato nell’ambito dei sistemi di produzione e utilizzo e un periodo di
Gli studi superiori al Liceo Scientifico e una laurea magistrale in Ingegneria Energetica al Politecnico di Milano. Un dottorato nell’ambito dei sistemi di produzione e utilizzo e un periodo di ricerca in California. Questo il percorso che ha portato la trentenne Elena Crespi a ricevere il premio “Young Scientists 2023” dalla Hydrogen Europe Research
È di Varese la scienziata dell’anno per la ricerca sull’idrogeno. Elena Crespi, trentenne, nata e cresciuta nel quartiere varesino di Giubiano, ha ricevuto il premio europeo “Young Scientists 2023” lo scorso novembre. Un riconoscimento conferito dalla Hydrogen Europe Research, organizzazione internazionale che comprende 150 Università e Centri di ricerca di 29 Paesi. Il premio è stato istituito per dare visibilità al lavoro di studenti, dottorandi e giovani ricercatori under 35 che lavorano nell’ambito della Clean Hydrogen Partnership, iniziativa europea per ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera.
Come è nato l’interesse verso l’idrogeno? Quale percorso professionale ha intrapreso?
Ho frequentato il Liceo Scientifico a Varese, poi mi sono iscritta a Ingegneria Energetica al Politecnico di Milano per studiare le energie rinnovabili, con l’idea di poter contribuire a migliorare in qualche modo il nostro pianeta. Durante la magistrale, ho seguito un corso legato alla produzione e all’utilizzo di idrogeno. Come tesi magistrale, ho scelto di occuparmi di un progetto sull’utilizzo di idrogeno per la produzione di energia elettrica con un sistema a fuel cell (pila a combustibile, ndr) e dopo la laurea sono rimasta al Politecnico per continuare a seguire il progetto. Ho poi deciso di fare il dottorato, continuando a occuparmi di sistemi di produzione e utilizzo di idrogeno. Ho avuto la possibilità di viaggiare in Europa per conferenze e riunioni di progetti e anche l’opportunità di svolgere un periodo di ricerca in California, all’Università di Irvine. Piacendomi il lavoro da ricercatrice, al termine del dottorato, ho trovato una posizione nel centro Sustainable Energy (SE) della Fondazione Bruno Kessler (FBK), dove lavoro da due anni.
In cosa consiste il suo lavoro?
In FBK, con i colleghi dell’area HyRes (Hydrogen and resilient energy systems), sto seguendo diversi progetti europei (principalmente finanziati dalla Clean Hydrogen Partnership) e consulenze industriali, per contribuire all’avanzamento tecnologico dei sistemi basati sull’idrogeno e per supportare le imprese che si avvicinano a questo settore. Il mio lavoro si svolge in parte in laboratorio e in parte in ufficio. In laboratorio testiamo nuove celle di elettrolisi (per produrre idrogeno rinnovabile) e fuel cell (per riconvertirlo in energia elettrica rinnovabile), al fine di migliorare la loro efficienza e ridurne i costi di produzione. Accanto all’attività sperimentale, c’è poi un’attività di modellazione di questi sistemi, per simulare il loro comportamento e contribuire all’ottimizzazione del design e del funzionamento. Infine, ci sono le l’attività di ricerca bibliografica e di divulgazione dei risultati con la produzione di report e articoli scientifici.
A quali progetti sta lavorando?
In questo momento sto lavorando a due progetti europei, Switch e Prometeo. Entrambi si occupano di celle a ossidi solidi ad alta temperatura, che operano a circa 700 gradi e hanno la potenzialità di raggiungere efficienze elevate. Il progetto Prometeo ha l’obiettivo di progettare, costruire e testare un sistema di elettrolisi a ossidi solidi completamente integrato con fonti di energia elettrica rinnovabile, per produrre idrogeno rinnovabile con elettricità da fotovoltaico ed eolico e calore da impianti a contrazione solare, attraverso stoccaggi di energia termica. Il progetto Switch ha l’obiettivo di testare sistemi a ossidi solidi invertibili, capaci di produrre idrogeno senza interruzione. Il sistema lavora quindi in modalità di elettrolisi quando è disponibile un eccesso di energia elettrica da sole o vento, producendo idrogeno. Quando l’elettricità rinnovabile non è invece disponibile, il sistema funziona in modalità fuel cell, utilizzando biogas per produrre contemporaneamente idrogeno ed elettricità. Tra le consulenze e collaborazioni industriali attive, posso citare diverse attività legate al test di celle di elettrolisi a bassa temperatura (60°C-80°C, quali PEM – Proton Exchange Membrane – o alcalini) e attività di analisi tecnico-economica per il dimensionamento ottimale di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile.
È stata nominata scienziata dell’anno per l’idrogeno. Un premio che le è stato conferito dalla Hydrogen Europe Research. Cosa ha significato ricevere questo riconoscimento?
Questo premio è l’indicazione che sto lavorando bene, che sto facendo qualcosa di utile nel settore. Un incoraggiamento a continuare il mio lavoro. L’attenzione mediatica che ne è derivata è stata poi un’occasione per poter parlare di idrogeno e del ruolo che queste tecnologie possono avere.
Se dovesse fare un bilancio: in Italia, qual è lo stato di avanzamento dei lavori su queste tematiche? Le imprese sfruttano le opportunità che derivano dall’idrogeno nelle proprie produzioni industriali?
Nel nostro Paese ci sono diverse imprese che negli ultimi anni si sono avvicinate al settore, dedicandosi principalmente alla produzione di idrogeno, attraverso la realizzazione di elettrolizzatori e delle infrastrutture per l’accumulo e la distribuzione, ai servizi, con consulenze, studi di fattibilità, e ingegneria e all’uso di idrogeno nella mobilità. Secondo l’osservatorio idrogeno di H2IT (l’Associazione Italiana Idrogeno, con più di 100 soci, tra grandi, medie e piccole imprese, Centri di ricerca e Università), la filiera è ancora in piena evoluzione e i progetti di ricerca e sviluppo sono ancora prevalenti. Molte aziende, però, dichiarano di avere progetti di ricerca ad alto livello e di essere pronte per la commercializzazione. Accanto alle realtà produttive che autofinanziano la loro ricerca, ci sono imprese che sfruttano i fondi europei, nazionali e regionali. Ad esempio, alcune aziende hanno ottenuto bandi europei (come Horizon Europe) per sviluppare partnership internazionali all’interno di progetti di innovazione e dimostrazione e nelle cosiddette “Hydrogen Valleys”. Tra le criticità emerge la mancanza di un quadro normativo chiaro e regolamenti a livello nazionale, che rendano stabili nel tempo le condizioni di investimento. A limitare la diffusione di queste tecnologie c’è poi l’alto costo di investimento, derivante in parte dalla loro bassa maturità. Il costo dell’idrogeno rinnovabile, legato all’alto costo degli elettrolizzatori, alla limitata disponibilità di risorse rinnovabili (con produzione non continua) e all’elevato prezzo dell’energia elettrica, risulta attualmente superiore al costo dei combustibili fossili che potrebbe sostituire. A tal proposito, per promuovere la filiera dell’idrogeno nel suo complesso, dalla produzione all’accumulo, passando per la distribuzione e gli usi finali, sono stati stanziati con il Pnrr 3 miliardi di euro di investimenti. È, inoltre, in fase di consultazione pubblica il Decreto Ministeriale tariffe Opex, relativo al meccanismo di supporto per impianti di produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili. Tra questi, quindi, è incluso anche l’idrogeno.
Perché l’Italia dovrebbe investire in questo ambito? Quali sono i benefici?
L’idrogeno può svolgere un ruolo rilevante all’interno della transizione energetica. È un vettore energetico che può essere utilizzato per stoccare energia rinnovabile anche per lunghi periodi e per la decarbonizzazione dei settori definiti “hard-to-abate” (difficili da decarbonizzare, ndr), in cui la conversione all’elettrico non è possibile, come, per esempio, la produzione di acciaio, vetro, cemento o ceramica. Inoltre, considerando che l’Italia è il quinto Paese europeo per consumo di idrogeno grigio (prodotto a partire da combustibili fossili) nell’industria e il quarto per produzione di idrogeno grigio, la produzione di idrogeno rinnovabile contribuirebbe in modo sostanziale anche alla decarbonizzazione di settori che già usano questa tecnologia. Lo sviluppo dell’economia dell’idrogeno è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione Europea, che ha fissato un target di penetrazione dell’idrogeno nel mix energetico europeo pari a 13-14% entro il 2050 (dall’attuale 2%). Il REPowerEU ha, inoltre, fissato un target di produzione di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile in Europa entro il 2030 e l’importazione di ulteriori 10 tonnellate. A tal proposito, l’Italia è in una posizione strategica per consentire lo sviluppo di un mercato internazionale, grazie ai gasdotti che la collegano sia con i Paesi del Nord Africa, sia con altri Paesi europei.