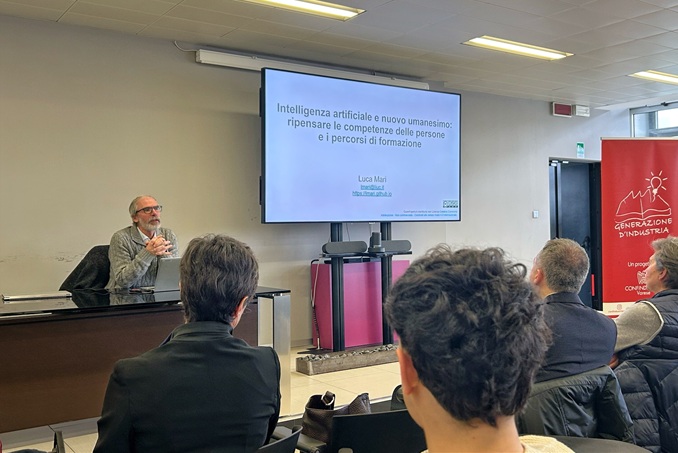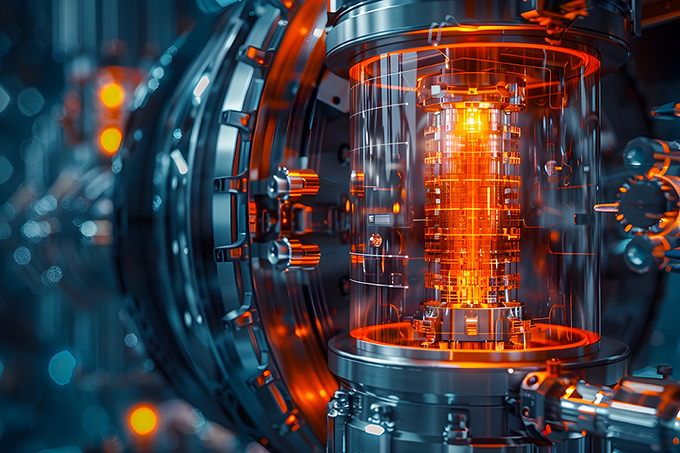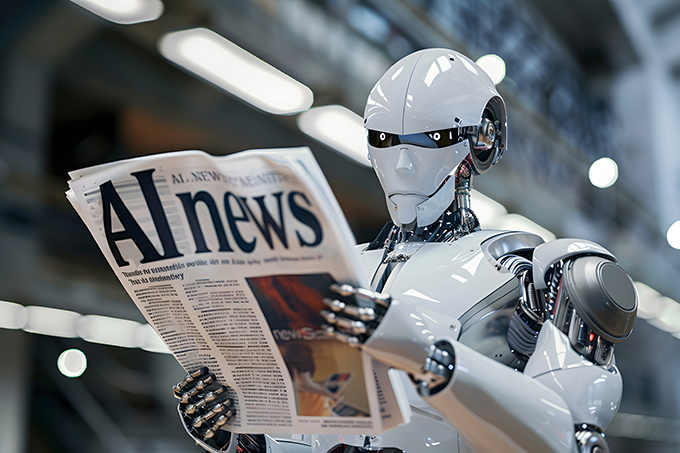La scienza non è un’opinione
Vorrei partire da un caso personale. Tempo fa venni invitato da una giornalista conosciutissima in una trasmissione televisiva pomeridiana. Si sarebbe dovuto parlare di UFO. Quali sono i punti f
Quali sono i punti fermi che le discipline scientifiche offrono ad una società dove tutto sembra essere diventato relativo? Esiste una verità oggettiva che, dati alla mano, non può essere messa in discussione? Il punto di vista del “nostro” divulgatore scientifico, Luigi Bignami, che risponde così al virologo Roberto Burioni che su Facebook ha scritto: “La scienza non è democratica”. Aprendo così, suo malgrado, un dibattito
Al momento di entrare in scena vennero dapprima presentati degli ufologi: chi sosteneva di avere le prove dell’esistenza degli UFO, chi, addirittura, di avere le prove che gli Indiani d’America avevano incontrato gli alieni. La stessa conduttrice affermava di aver “visto qualcosa di strano” in gioventù, di inspiegabile. Dopo di loro venne presentato il sottoscritto, dicendo che rappresentavo la voce della “scienza”. Non sto a raccontare come andò il dibattito, ma vorrei soffermarmi su una frase importante detta dalla conduttrice: “Lei – rivolta a me – non può sostenere che quel che dice è corretto perché lo dice la scienza, la sua è un’opinione, diversa dagli altri ospiti”, il tutto sostenuto da un gran battimani. A quel punto capii che non c’era più nulla da fare. Secondo la conduttrice, ma è quel che sta diventando senso comune, quel che sostiene la scienza è un’opinione da mettere su un piatto della bilancia, mentre sull’altro si può mettere di tutto: dal “contattista”, a colui che sostiene che la Terra è piatta, fino a chi sostiene che i vaccini siano dannosi. Siamo entrati nell’era della società nella quale tutto è relativo, anzi chi ha delle certezze sbaglia, e, dunque, anche la scienza è relativa.
A conferma di quel che è stata un’esperienza personale, negli ultimi mesi il “caso-Burioni” ha fatto molto clamore tra i social. Roberto Burioni, scienziato, microbiologo e virologo, ha una pagina su Facebook molto seguita. In un suo post dimostra come i casi di meningite che si sono registrati in Italia nulla hanno a che vedere con il gran numero di immigrati che arrivano dall’Africa. Più recentemente è intervenuto in modo altrettanto serio e documentato sull’importanza dei vaccini. Tra i molti che hanno applaudito alle parole di Burioni, alcuni hanno, però, messo in dubbio i dati scientificamente riportati. E quel che è deleterio è il fatto che tra coloro che si sono messi contro lo scienziato vi sono uomini politici, che nulla o pochissimo sanno di scienza, ma che hanno un forte seguito popolare. Il professore ha così cancellato alcuni commenti e in modo risoluto ha scritto: “…tutto quello che io scrivo è corretto e, inserendo io immancabilmente le fonti, chi vuole può controllare di persona la veridicità di quanto riportato…
La scienza non è democratica”. Questa frase è risuonata e continua a risuonare tra i social come un tam-tam, tant’è che da affermazione è diventata domanda. E allora chiediamoci anche noi: “La scienza può essere democratica?” La risposta oggettiva è “no”, perché diversamente si verrebbero a minare le fondamenta stesse della scienza. Da che questa disciplina ha assunto il ruolo attuale, da Galileo Galilei in poi, la scienza deve seguire regole ben precise nel suo progredire, le regole che definiscono il metodo scientifico. Prima di giungere a una qualunque spiegazione di un fenomeno, infatti, sono necessari l’osservazione sperimentale di quel fenomeno, quindi la formulazione di un’ipotesi che cerca di spiegarlo, poi il controllo di tale ipotesi attraverso osservazioni da chiunque li voglia realizzare, controlli che possono essere compiuti direttamente in natura o in laboratorio. Dopo tutto ciò si potrà arrivare a definire una teoria. Così facendo le nostre conoscenze progrediscono in modo corretto e, dunque, non vi sono spazi per i sé o per i ma. Questo metodo dà ragione in modo inequivocabile al concetto del perché le conclusioni scientifiche non siano democratiche.
Da Galileo Galilei in poi, la scienza deve seguire regole ben precise nel suo progredire, le regole che definiscono il metodo scientifico: l’osservazione sperimentale, la formulazione di un’ipotesi, il controllo di tale ipotesi e solo alla fine la teoria