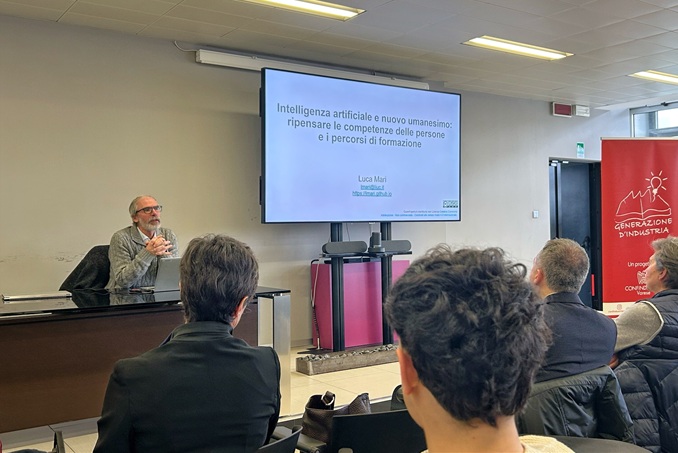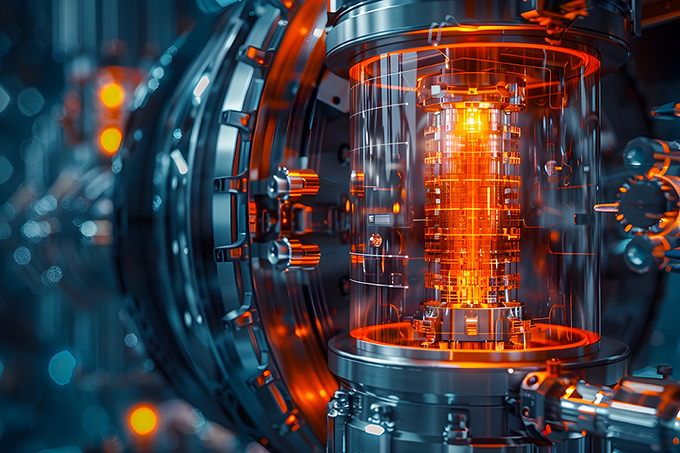Basta bufale!
Fermiamo le fake news, ma come? Abbiamo chiesto a tre protagonisti varesini della comunicazione, che operano nel panorama nazionale, di raccontarci come vivono oggi la loro professione al tempo della
Fermiamo le fake news, ma come? Abbiamo chiesto a tre protagonisti varesini della comunicazione, che operano nel panorama nazionale, di raccontarci come vivono oggi la loro professione al tempo della post-verità
RICONOSCERE UNA BUFALA
Francesca Bello, Senior Digital Strategist Ready2fly
Le fake news sono una grande occasione per ripensare il giornalismo”, ha sottolineato proprio a Varese, Carlo Purassanta, Amministratore Delegato di Microsoft Italia. Concordo: penso che il giornalismo, e in particolare quello italiano, abbia oggi l’occasione di svincolarsi dagli errori del recente passato e tentare di recuperare quell’autenticità e genuinità che lo contraddistinguevano. In generale siamo testimoni di una crescente esigenza di tornare agli elementi fondamentali del giornalismo, sia per dare fiducia che per mantenere l’attenzione dei lettori. Allo stesso modo penso che sia utile educare l’utente finale alla lettura critica e consapevole, poiché, a seguito del bombardamento mediatico, dell’effetto dei social e delle (purtroppo) radicate carenze televisive in ambito di una “vera” informazione, l’attenzione del pubblico si è ormai uniformata ad un livello talmente basso, che ascoltare servizi sui primi bagnanti dell’anno a Rimini o su pazzi che si fanno saltare in aria in mezzo alla folla, suscita la stessa scarsa reazione a livello sia attentivo che critico.
Dal mio punto di vista è cambiata la gestione dell’informazione: lavorando con clienti importanti e multinazionali, mi sono accorta che il minimo errore o notizia “fake” o fuorviante può innescare una reazione a catena incontrollabile, impossibile da fermare proprio a causa della diffusione a macchia d’olio delle fake news: ad esempio, mi è capitato recentemente di dover moderare una vera e propria crisi scaturita da una fake news riportata su un importante quotidiano nazionale, nel quale veniva travisato l’esito di un discorso tra due parti. Una news sbagliata, che lo si voglia o no, può creare grossi problemi. La necessità è di avere sempre maggiore responsabilità nello scrivere o nel postare, andando veramente a fondo delle notizie; responsabilità anche da parte di chi legge, che ora più che mai è tenuto (grazie anche a delle ottime iniziative di Google e Facebook) a segnalare le possibili fake news in modo tale da fermare l’emorragia mediatica che queste provocano.
L’impatto di fake e controfake è fortissimo e in molti casi pericoloso: c’è scarso senso critico nelle masse, che ingurgitano notizie senza analizzare. Questo in parte è dovuto ad una mancanza di educazione, sia all’interno dei nuclei familiari che nelle scuole, in materia di corretta navigazione, se non di verifica di quanto viene fruito giornalmente: al giorno d’oggi i maggiori fruitori di questo genere di notizie sono i “millennials”, adolescenti il cui carattere è in formazione e che quindi hanno una capacità di assorbimento come quella delle spugne. Suggerisco ai giovani di partecipare all’International Factchecking Day (2 aprile 2018), una giornata nata per promuovere la cultura della verifica delle fonti in tutto il mondo.
Qualche consiglio pratico però si può offrire. Come suggerisce Craig Silverman, esperto di fact-checking e giornalista di Buzzfeed, bastano solo 5 piccoli accorgimenti per riconoscere una fake news:
1) Controllare la url della notizia.
2) Leggere la pagina “Chi Siamo”: molti siti che diffondono “fake news” spesso hanno un disclaimer in cui indicano che si tratta di un sito di satira.
3) Fare attenzione alle dichiarazioni: se provengono da una persona nota, basta selezionare la frase e lanciare una ricerca su Google tra virgolette. In questo modo si può controllare se le stesse parole sono state riprese anche da altre fonti; in caso contrario, meglio approfondire.
4) Fare una ricerca inversa delle immagini: basta andare su Google Immagini e caricare un’immagine sospetta per scoprire se è stata già pubblicata altrove o se si riferisce a un altro evento.
5) Usare la massima cautela. “Se una storia sembra troppo bella per essere vera, oppure ti provoca una forte reazione emotiva, è meglio calmarsi per un momento”, è il consiglio finale di Silverman.
PRIMA DI SCRIVERE, PENSATE
Marco Alfieri, Responsabile Content Strategy & Newsroom Eni
Diciamo la verità: le bufale, senza scomodare termini stranieri, sono sempre esistite. Il tema non è nuovo, tant’è che ai corsi di giornalismo, anche basic, insegnano da sempre come fare una verifica. Oggi però, succede dell’altro: da qualche anno, grazie alla tecnologia, che ha rotto il monopolio dell’informazione dei giornali tradizionali, tutti diventano potenzialmente produttori di notizie. Tra opportunità e rischi, è ovvio che la questione diventa più difficile per chi fa informazione di mestiere. Con un arsenale tecnologico che spara bufale, l’ecosistema è molto vulnerabile. Questo dovrebbe imporre a chi fa comunicazione di professione, e non solo al giornalista, di lavorare in maniera maniacale per una produzione di qualità tale da far esaltare la differenza. In Italia, però, ciò avviene poco, complice la smania di inseguire like e velocità. Ma non dev’essere così. Cosa cambia nel mio lavoro? Se prima mettevo due occhi per verificare una notizia, ora ce ne metto tre. Occorre, però, naturalmente frenare l’ansia di arrivare prima, anche su quei canali che implicano rapidità. Persino su Twitter. Prima di scrivere, bisogna pensare. Semplicemente. È interessante ed esemplare in questo senso il lavoro di brand journalism di Eniday (il progetto giornalistico di Eni, “L’energia è una bella storia”). Grazie alla collaborazione con la società Contently, abbiamo l’aiuto di un software con un’intelligenza artificiale, una sorta di assistente virtuale, che ci affianca nell’editing e ci aiuta nel fact checking. In pratica, ci sono ben cinque voci che devono essere soddisfatte in un testo prima della pubblicazione. Tra queste: la verifica che non ci sia plagio, il check sul funzionamento degli hyperlink, il controllo dell’affidabilità delle fonti. Immaginate se le redazioni usassero questo sistema. È interessante, invece, che questo succeda dentro un’azienda, che è diventata nel tempo media company e che deve partire, come molte imprese, ma ancor di più quelle del settore dell’energia, da una situazione di pregiudizio da parte del lettore. Una bella sfida: nonostante una premessa apparentemente svantaggiosa, si ha l’opportunità di arrivare a una maggioranza silenziosa, che non ha pregiudizi, ma semplicemente non conosce il contesto. Il segreto? Comunicare con semplicità, empatia e autorevolezza.
IL POST GIORNALISMO AL TEMPO DEI LIKE
Paolo Costa, Capo ufficio stampa Consiglio Regionale della Lombardia
Il Villaggio Globale è sorto dopo anni e anni di sviluppo e di crescita del benessere sociale, raggiungendo il massimo splendore con l’affermazione della televisione. Oggi, all’improvviso, ci troviamo immersi nelle sue macerie. Addio massificazione, siamo diventati la società liquida: ognuno può abbeverarsi alle sorgenti dell’informazione avendo a disposizione mezzi diversi e numerosissime voci e assemblando un suo palinsesto personale, particolare e unico. Le news, considerate un genere di consumo tra i tanti, possono diffondersi incontrollate e rapidamente. E la viralità diventa l’humus facilmente permeabile alle fake news, che sono sempre esistite (vedi il codice penale articolo 656), ma che oggi sono più subdole, pervasive, dannose.
Il dibattito che ha investito i giornali in questo periodo avrebbe però dovuto assumere un’altra piega e non limitarsi al problema pur importante di come scovare e distruggere le bugie del web o dei social. Mi spiego. Quando nel novembre scorso l’Oxford Dictionary scelse post truth come parola dell’anno si riferiva a una definizione per quelle “circostanze in cui i fatti obiettivi influiscono sull’opinione pubblica meno degli appelli alle emozioni e alle convinzioni personali”. è stata così individuata una precisa e fondamentale caratteristica del mondo contemporaneo: non conta più se una cosa è vera o falsa, ma se fa opinione, se è condivisa, se riesce a moltiplicare i like. Piacere è più importante di essere veri, l’aspetto emotivo prevale sulla sostanza. è un contesto che apre la via a questioni profonde: che cos’è la verità? (si veda la significativa copertina del Time: Is Truth Dead?) Di quali fonti ci fidiamo? Siamo disposti a compiere il “sacrificio” dell’approfondimento, dell’analisi, del confronto o ci fermiamo alla superficie? Senza una risposta precisa a queste domande, il modello sociale cui siamo destinati è sempre di più quello individualista, dove la pubblica opinione si fonda sulle sensazioni e le opinioni personali non sono mai il risultato di relazioni che cercano una sintesi.
L’epoca della post-verità vede le istituzioni (tutte) in crisi di popolarità e credibilità e perciò fare l’ufficio stampa di un parlamento regionale è tutt’altro che semplice. Occorre presidiare le fonti continuamente, alimentare i canali informativi con notizie che magari “non bucano” ma hanno un valore sociale, sfidare la mentalità corrente promuovendo i concetti di democrazia e partecipazione, tornare a seguire i principi della professione giornalistica. Capire, approfondire e spiegare costa impegno. Ma è la strada obbligata se si vuole risalire la china della fiducia (non è accettabile che solo il 23 % degli italiani abbia una stima incondizionata nei confronti degli operatori dell’informazione, come emerge da una recente indagine Reuters).
Per approfondire leggi anche: